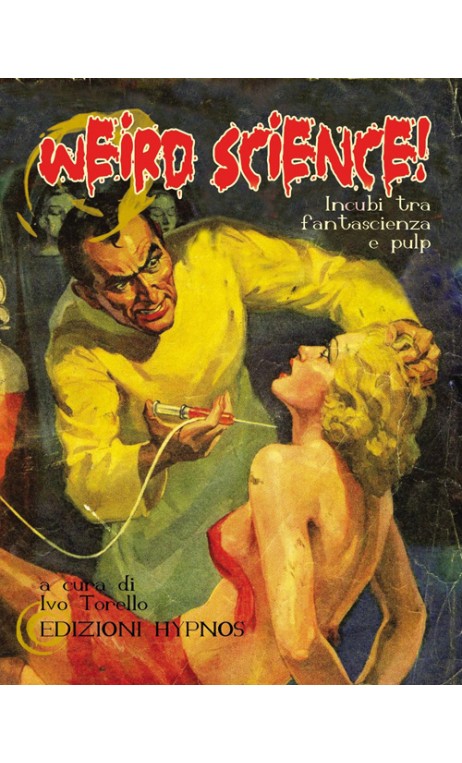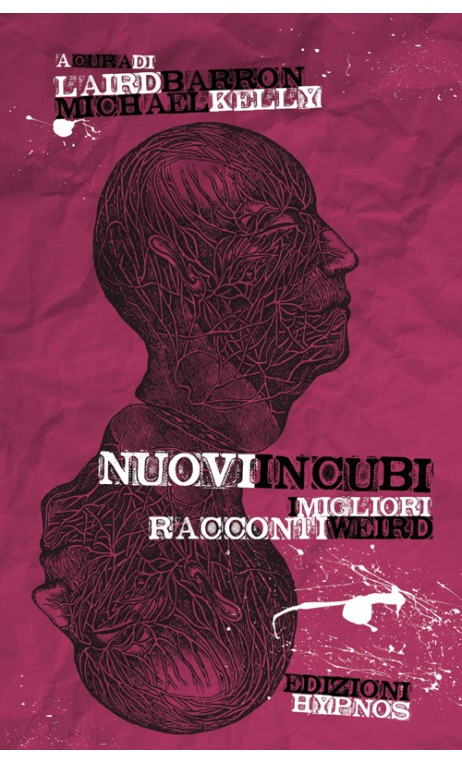*********************************************************************************************************************
![]()
Gli appassionati ormai lo sanno: la SF non è solo divertimento frivolo, avventure spaziali adrenaliche e/o immaginifiche, passatempo e dipinti cosmici psichedelici; e mentre l'editoria nostrana rifugge la parola "
fantascienza" come fanno i vampiri con l'aglio, negli States la SF frequenta le aule e biblioteche universitarie.
Nel 2014 la
Wesleyan University Press ha stampato un' antologia a tema, curata da Gerry Canavan e Kim Stanley Robinson, intitolata "
Green Planets - Ecology and Science Fiction" (ispirata dall'antalogia "
Red Planets: Marxism and Science Fiction", curata da China Mieville e Mark Bould); l'antologia comprende racconti e saggi a tema ecologia, inquinamento ambientale ed ecocriticismo in relazione, ovviamente, alla Science Fiction. Un'antologia molto bella, che consiglio caldamente a chiunque è particolarmente interessato a queste tematiche.
Ma in Italia purtroppo siamo destinati a leggere in inglese, perchè è quasi impossibile che opere del genere vengano tradotte in italiano e perchè ancora più difficile è immaginare che i nostri editori comincino a pubblicare opere di questo tipo (per questo motivo l'articolo/saggio firmato da Fabio Feminò, "Macrocittà del Futuro", apparso sull'
UCZ #148, è stata per me una graditissima sorpresa!).
![]()
Fino a qualche anno fa noi Italiani avevamo almeno la fortuna di poter accedere alle opere pubblicate dalla amata e compianta
Editrice Nord; in particolare, nella collana
Grandi Opere Nordè stata pubblicata l'antologia
Storie del Pianeta Azzurro, curata da Sandro Pergameno e contenente racconti e romanzi brevi inediti di autori del calibro di
R. Silverberg, G. Dickson, P. Anderson, T. Sturgeon, H. Ellison, G. Wolfe, A. Budrys, T. Carr, N. Spinrad, J. Varley, M. Bishop, C. Willis, W. Guin, O.S. Card, D. Knight e F. Pohl.
I temi toccati spaziano dall'ecologia all'olocausto nucleare, dall'inquinamento ambientale alla sovrappopolazione, dai paradisi tecnologici all'alienazione, dalla povertà alla follia ed all'alienazione che impera nella nostra società fino a scenari della Terra di un lontanissimo futuro; insomma, si parla del futuro del nostro pianeta...di casa nostra...della nostra esistenza!
Un'antologia caldamente raccomandata a tutti gli appassionati (e che dovrete cercare nei canali dell'usato) e della quale vi riproponiamo l'introduzione firmata da
Sandro Pergameno.
Arne SaknussemmLa Terra del futuro: castelli nel cielo o rovine nella polvere?«
Per quanto gli scrittori di fantascienza possano giocare col tempo, saltare nel passato, o trasportarsi in mondi alternati, la loro vera casa è il futuro. Le altre arene possono essere piacevoli luoghi di soggiorno o creativi terreni di gioco, ma l'aspetto missionario dello scrittore di fantascienza, in contrasto con i suoi scopi artistici, i suoi bisogni pratici, o i suoi momenti "sportivi", necessita di un'opportunità di predicare la ricerca della salvezza, un cambiamento nell'etica, o nelle morali o nelle religioni, un nuovo modo di pensare o addirittura un nuovo stile di vita... Gli scrittori di fantascienza, come gruppo, hanno un'inestinguibile e insradicabile bisogno di mettere il mondo sull'avviso contro i pericoli che ci attendono, e solo il futuro può essere cambiato.» Con queste parole James Gunn iniziava un capitolo del suo ottimo saggio
Mondi alternativi (
Alternate Worlds) intitolato «
La forma delle cose a venire», con un ovvio riferimento al classico libro di Herbert George Wells. Ci siamo permessi di riprendere la bellissima introduzione di Gunn perché ci sembra che queste frasi rendano alla perfezione un concetto per noi fondamentale nella disamina del fenomeno fantascientifico, e cioè che uno degli aspetti principali (se non il principale in assoluto), e certo il più importante dal punto di vista storico e sociale, di questo peculiare genere narrativo è quello della predizione del futuro, intesa sia come estrapolazione delle varie tendenze scientifiche e tecnologiche, sia come «avviso», «prevenzione», «messa in guardia» dai pericoli che possono nascere da queste nuove tendenze stesse.
In un certo senso in effetti potremmo anche affermare che la fantascienza, come genere letterario, è nata proprio come disamina delle possibilità che la scienza offre all'uomo, come fantastica speculazione sui probabili sviluppi futuri delle attuali conoscenze tecnologiche.
Avremmo dunque potuto includere in questo volume qualsiasi storia di «
science fiction» (escludendo la «
fantasy», che, per sua definizione, è un filone parallelo alla fantascienza ma da questa distaccato da canoni a volte abbastanza sottili): diciamo dunque che la nostra scelta è andata stavolta ad opere incentrate sul futuro del nostro pianeta. Abbiamo così limitato in parte il nostro raggio d'azione, ma non di molto: ci siamo sbizzarriti infatti a ricercare racconti di tema utopistico o antiutopistico (o distopico, se preferite questo termine oggi così in voga), storie di catastrofi ecologiche o atomiche, vicende sul lontano futuro dell'umanità e su una Terra alla fine del tempo.
Temi dunque molto disparati tra loro, ma che ci hanno permesso di radunare molti racconti e romanzi brevi che volevamo da tempo presentare ai nostri lettori: alcuni sono racconti che hanno vinto dei
premi Nebula (visto che abbiamo già dedicato due volumi alle storie che hanno vinto il premio Hugo), altre sono storie classiche apparse negli anni quaranta e cinquanta, altre infine sono storie tra le migliori apparse in questi ultimi anni oltreoceano.
La maggior parte di queste storie, pur essendo tutte molto varie e diverse tra loro, possono venir fatte rientrare nel filone «distopico», intendendo con questo termine qualsiasi vicenda focalizzata su un futuro negativo per l'umanità, vale a dire su una società futura che sia all'opposto del mito dell'Utopia, dello Stato Ideale. In senso lato questa negatività futura può derivare non solo da una degenerazione del potere politico (che potrebbe accentrarsi con effetti deleteri nelle mani di un uomo solo o di un'oligarchia militare, teocratica o tecnocratica) ma anche da una qualsiasi altra causa di disgregazione della società umana, sia questa un cataclisma ecologico provocato dall'incoscienza umana, sia un olocausto nucleare derivante anch'esso dalla follia dell'uomo.
Il mito dell'Utopia, cioè dello Stato Ideale, del Paradiso in Terra, è molto antico ed ha origini che precedono quelle della fantascienza (a meno che non si voglia far rientrare nella fantascienza anche il genere utopistico, ma questo è un altro discorso che forse è meglio evitare in questa sede). Già gli antichi greci con
Platone e
Luciano di Samosata avevano iniziato a esplorare i territori del mito utopistico, ma chi coniò per primo questo termine fu l'inglese
Thomas More nel 1516, appunto nel suo
Utopia, una parola che sta ambiguamente a metà tra «eutopia» (letteralmente «un posto migliore») e «outopia» («nessun luogo»). Vale a dire che «utopia» è una terra mitica e paradisiaca che però non esiste nel nostro mondo (ancora).
Si potrebbe dire che le storie utopistiche sono fantascienza in quanto sono esercizi di ipotetica sociologia e scienza politica. Viceversa si potrebbe obiettare che solo quelle utopie che si fondano su presupposti di avanzamenti scientifici si qualifichino come SF. Ma questa è una disquisizione oziosa che potrebbe portarci molto al di fuori del nostro seminato. Vediamo dunque come gli autori di fantascienza hanno trattato questo genere.
Gli scrittori dell'ottocento furono i primi a focalizzare la loro attenzione su questo filone, e ciò fu dovuto, a nostro avviso, soprattutto alla rivoluzione tecnologica degli inizi del secolo. Non fraintendeteci: la rivoluzione tecnologica non produsse all'inizio molti stimoli utopistici negli scrittori dell'epoca. Al contrario, gran parte delle storie utopistiche dell'ottocento sono caratterizzate da una forte vena di romanticismo anti-scientifico.
The Coming Race (1870) di
Bulwer Lytton appartiene di diritto più alla tradizione occultistica di questo autore che alle utopie scientifiche. Il satirico
Erewhon (1872) di
Samuel Butler e il suo seguito sono senz'altro opere pastorali e anti-tecnologiche, ammesso sempre che siamo utopistiche.
After London (1885) di
Richard Jefferies è il romanzo più estremista di tutti nella sua nostalgia della barbarie, e presenta immagini di città morte che hanno avvelenato la Terra.
Questo conservativismo nostalgico tuttavia è più inglese che americano: in effetti non raggiunse affatto l'America, che stava diventando già allora la vera patria del progresso. Il celebre
Looking Backward (1888) di
Edward Bellamy, riportò il mito utopistico a un glorioso apice di popolarità, e fu presto seguito da molti altri nello stesso stile.
Il libro di Bellamy era indubbiamente molto ingenuo, ma divenne comunque l'archetipo di un'intera scuola di utopie meccanizzate, tra cui ricordiamo
A.D. 2000 (1890) di
Alvarado Fuller e
The Crystal Button (1891) di
Chauncey Thomas.
Ma fu soprattutto
Herbert George Wells, per tornare in Inghilterra, che diede nuova spinta al genere con i suoi
A Modem Utopia (1905),
Men like Gods (1923) e
The Shape of Things to Come (1933).
Hugo Gernsback, l'altro padre della fantascienza (se vogliamo considerare Wells come il primo) e fondatore di «
Amazing Stories», la prima rivista dedicata interamente a questo genere, era anch'egli un convinto «euchroniano». Gernsback credeva fermamente che uno stato utopistico sarebbe stato il risultato inevitabile del progresso tecnologico: a parte la stesura del romanzo
Ralph 124C41 + (1911-12), si potrebbe dire che egli creò il genere letterario della «scientifiction» (così chiamava lui la fantascienza) principalmente come mezzo promotore dei magnifici potenziali della tecnologia moderna.
All'epoca della nascita di «
Amazing» tuttavia, un nuovo tipo di critica all'utopia era ormai in atto: critica sulla base di ciò che è desiderabile, e non di ciò che è pratico.
Anatole France in
The White Stone (1905) fece dire a un personaggio (era un cittadino di una futura utopia) che la pace e la ricchezza vanno bene ma non sono sufficienti a garantire all'uomo la felicità.
A causa di queste circostanze dunque, nonostante l'entusiasmo di Hugo Gernsback, la fantascienza non è mai stata un genere molto utopistico: semmai, riallacciandoci al discorso iniziale potremmo dire che le preoccupazioni degli autori di SF hanno quasi sempre prevalso sull'ottimismo di Gernsback.
Certo, nelle prime storie degli anni venti e trenta troviamo una pletora di racconti più o meno stereotipati di società felici, ordinate e giuste dove sono state debellate povertà e malattie.
Le obiezioni più violente a questo tipo di storie vennero, oltre che dagli autori delle riviste di fantascienza, anche da autori al di fuori del campo:
Aldous Huxley,
George Orwell,
Ayn Rand,
L.P. Hartley,
Bernard Wolfe portarono tutti attacchi violentissimi a queste utopie sociali che in un certo senso si riagganciavano agli ideali comunisti di Carl Marx e dei suoi seguaci.
Se
George Orwell dipinge un devastante ritratto di una tirannica dittatura di stampo comunista in
1984 (1948), riprendendo temi già espressi in maniera non altrettanto efficace dal russo
Eugenio Zamiatin in
Noi (My, 1922) e da
Ayn Rand in
La vita è nostra (Anthem, 1937),
Aldous Huxley distrugge con il suo
Il mondo nuovo (Brave New World, 1932) gli ideali del positivismo scientifico manifestati dalle numerose utopie descritte da Wells, che fu certamente il più grande sostenitore, nel primo novecento, dei valori socialisti e scientifici.
Anche molti degli autori delle riviste di sf non erano molto convinti delle idee di Gersnback: alcuni già avvertivano il sorgere di dubbi e di un certo senso di pessimismo.
Miles J. Breuer in
Paradise and Iron (1930),
Laurence Manning e
Fletcher Pratt in
City of the Living Dead (1930) e
John Wood Campbell jr. in
Twilight (1934, scritto sotto lo pseudonimo di
Don A. Stuart) prevedono tutti la decadenza della civiltà umana come inevitabile conseguenza di una troppo marcata dipendenza dalle macchine. L'idea era già stata magistralmente trattata da un autore del primo novecento,
E.M. Forster, che nella sua unica escursione nel campo fantascientifico,
The Machine Stops (1909), aveva descritto un mondo sotterraneo, i cui abitanti vivono in celle separate e solitarie, assistiti in tutti i loro bisogni dall'onnipotente Macchina. I contatti tra le persone quasi non esistono più; la televisione è l'unica forma di comunicazione. Quando la Macchina si ferma, per un inspiegabile guasto meccanico o per semplice decadimento temporale, la civiltà crolla e tutti gli abitanti della città sotterranea, incapaci di far nulla e persino di uscire all'esterno, periscono miseramente nel panico più assoluto. I reietti che vagano sulla superficie abbandonata da secoli saranno gli unici superstiti umani della catastrofe.
Negli anni quaranta gli scrittori di fantascienza esaminarono con particolare interesse le antiutopie a sfondo religioso. I due esempi più validi e importanti sono senz'altro
L'alba delle tenebre (Gather Darkness, 1943) di
Fritz Leiber e
Rivolta nel 2100 (If This Goes On..., 1940) di
Robert Heinlein. Entrambi sviluppano un discorso su una futura dittatura religiosa rivestente i panni di un culto religioso. Nel primo, che è il più importante dei due romanzi pur essendo stato scritto dopo, un gruppo di scienziati sopravvissuti a una guerra atomica che ha avuto conseguenze catastrofiche per la Terra decide, un po' per brama di potere e un po' per mantenere un certo grado di civiltà ed evitare un ritorno completo alla barbarie, di creare una religione cinica e falsa, che domini sulle masse ignoranti con potere assoluto e prevaricatore e con il sussidio di una scienza grandemente avanzata. Nel momento in cui ha luogo l'azione, molti secoli dopo che questo è avvenuto, il mondo è cristallizzato in una sorta di medioevo futuro in cui la Gerarchia religiosa, che si trasmette ereditariamente l'appartenenza alla classe sacerdotale, usa non solo la scienza ma anche le armi ben più efficaci della paura, della psicologia e della superstizione per tenere le masse oppresse in una squallida servitù della gleba. Di nascosto dalla Gerarchia va però crescendo il malcontento del popolo, stanco di essere sfruttato così apertamente; tale malcontento viene poi incanalato nella direzione giusta, cioè quella della rivolta, da un gruppo sovversivo che ha scelto di rivestire i panni esteriori di un culto satanico, con tanto di streghe e stregoni, e di «familiari» tratti di peso dalla tradizione medioevale. La Nuova Stregoneria, i cui capi hanno coerentemente scelto i nomi di «Uomo nero» e di «Satanasso», ha inoltre imparato tutti i segreti scientifici così gelosamente custoditi dalla Gerarchia ed altri a quest'ultima ignoti ripescati nelle rovine della perduta civiltà del lontano passato; e la battaglia finale che vedrà il crollo della Gerarchia e del suo falso Dio si svolgerà appunto a colpi di falsa magia e di falsi miracoli: le immagini tridimensionali di fantasmi, lupi giganti, e diavoli fiammeggianti create dai proiettori solidografici dei ribelli incuteranno panico e terrore nell'animo dei preti della Gerarchia e sgretoleranno la struttura del potere ecclesiastico.
In
Rivolta nel 2100 Robert Heinlein descrive una situazione analoga: un'America futura ridotta a Stato teocratico-autoritario, con un Profeta Incarnato a capo del culto repressivo. Soltanto una rivoluzione sanguinosa, combattuta stavolta con armi più usuali, potrà riportare la democrazia.
In
L'undicesimo comandamento (The Eleventh Commandment, 1961)
Lester Del Rey presenta una religione scismatica ed eretica che, assunto il controllo del mondo, incoraggia, anzi ordina (è appunto questo l'undicesimo comandamento del titolo) al popolo di procreare in continuazione. L'unico peccato vero per gli uomini di questo mondo è quello di non avere figli. L'opera, che sembra, fino quasi alla fine, un violento attacco alla Chiesa Cattolica e alla sua opposizione al controllo delle nascite, termina invece con un clamoroso colpo di scena: il protagonista, che si batte per sconfiggere il potere teocratico, scoprirà che l'undicesimo comandamento è l'unica vera speranza che ha l'umanità di salvarsi dalla sterilità e dalla confusione dell'ibrida mescolanza delle razze mutanti create dalla bomba atomica.
In
Un amore a Siddo (The Lovers, 1961) e nel suo seguito
Gli anni del Precursore (A Woman A Day, 1968)
Philip José Farmer mostra la sua insofferenza nei confronti di qualsiasi imposizione mentale e tabù descrivendo un mondo futuro in cui Israele è diventato una delle massime potenze e il Precursore, l'infallibile profeta del culto ebraico, domina una società ultrapuritana dove tutto ciò che riguarda il sesso è accuratamente nascosto e cancellato. Per sfuggire all'oppressione di questa dittatura religiosa dalla terrificante chiusura mentale, Hal Yarrow, il protagonista di
Un Amore a Siddo, s'innamorerà di Jeannette, una lalitha, creatura extraterrestre dalle forme forme femminili, la cui razza si è evoluta sul pianeta Siddo a partire dallo stadio insettoide, e si unirà a lei in un sacrilego atto sessuale che la porterà alla morte.
La maggior parte delle antiutopie vide tuttavia la luce all'inizio degli anni cinquanta, periodo in cui, sotto l'impulso del direttore della rivista «
Galaxy»,
Horace Gold, venne particolarmente di moda l'anticipazione di tipo sociale (definita in Italia «fantascienza sociologica»). In questo filone i mutamenti del mondo futuro erano osservati attraverso l'ottica particolare data dalle relazioni sociologiche. Si analizzavano, cioè, le tendenze sociali fini a se stesse, astraendo dalle cause che le avevano provocate e trascurando spesso il singolo dato umano per descrivere il comportamento collettivo.
Il romanzo cardine di questo genere è il celebre
I mercanti dello spazio (The Space Merchants) di
Fred Pohl e
Cyril Kornbluth, uscito in volume nel 1953, dopo che una versione più breve,
Gravy Planet, era apparsa nel 1952 su «
Galaxy». I due autori hanno qui ipotizzato un'America futura sovrappopolata in cui il benessere e la qualità della vita vanno progressivamente diminuendo, mentre i monopoli industriali e le grosse agenzie pubblicitarie hanno esautorato il sistema politico e governano al posto degli uomini di governo, ridotti a meri fantocci nelle loro mani. L'uomo di questo terrificante futuro è un animale braccato dalla pubblicità, un consumatore forzato, una bestia da lavoro, un essere totalmente alienato dal lavaggio del cervello cui è sottoposto in continuazione. Il protagonista, Michael Courtenay, è uno dei dirigenti di una grossa agenzia pubblicitaria, ma, durante la campagna per la colonizzazione di Venere, subisce un capovolgimento improvviso e si ritrova sbalzato all'ultimo gradino della scala sociale: vivrà così di persona la orribile esperienza del consumatore. Tornato al potere con l'aiuto dei conservatori (a sua insaputa), egli cerca di cambiare le cose dall'interno (opponendo un «trust» buono a un «trust» cattivo). Naturalmente viene sconfitto, ma riuscirà alla fine a fuggire su Venere e a mantenere disponibile il nuovo pianeta per tutti coloro che non sono stati ancora totalmente inghiottiti dalla pubblicità.
Il tema «pubblicitario» è presente anche in
Il lastrico dell'inferno (Hell's Pavement, 1955) di
Damon Knight: qui i monopoli che si contendono i consumatori si sono eretti a veri e propri Stati riformando l'etica tradizionale: comprare i prodotti delle industrie concorrenti significa infatti compiere un peccato e consegnarsi alla dannazione. Attraverso una tecnica ipnotica, il consumatore è convinto, fin dalla nascita, di avere accanto a sé un angelo custode che lo guida nelle sue azioni, naturalmente lodandolo quando compra certi prodotti e rimproverandolo quando ne compra altri.
In
Gladiatore in legge (Gladiator at Law, 1954) il secondo romanzo composto da
Pohl e
Kornbluth, abbiamo invece un mondo futuro dominato dalle grandi Compagnie immobiliari, che hanno totalmente soggiogato la popolazione ai loro voleri. È un mondo inasprito dalla violenza, dalla passione per il profitto e da un arrivismo spietato che si sfrenano nelle città, veri incubi di cemento. La gente viene narcotizzata dagli spettacoli sanguinosi e brutali dei gladiatori che si uccidono tra loro nelle arene come negli antichi giochi romani. Chi ha un contratto di lavoro riceve cibo, casa, macchina; ma i disoccupati, i disadattati, gli sconfitti subiscono l'amara realtà della vita di Torcibudella, la squallida periferia urbana dove regna la violenza giovanile. In questo mondo l'avvocato Charles Mundin combatte una lotta impavida, nei vicoli delle città e nelle aule dei tribunali, contro un potentissimo «trust» immobiliare.
Ancora in
Rischio calcolato (Preferred Risk, 1959) di
Edson McCann (pseudonimo di Frederik Pohl e Lester del Rey), il potere assunto dalle compagnie di assicurazione diviene tale da condizionare l'esistenza del singolo individuo. La storia, che si svolge a Napoli, in un'Italia futura un po' di maniera, vede anche un personaggio, tal Zorchi, dotato della straordinaria capacità di farsi ricrescere gli arti, che provoca volontariamente incidenti in cui venga a rompersi gambe o braccia, per poter rivalersi appunto sulle compagnie assicurative.
Un classico dell'utopia negativa è
Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451, 1953) di
Ray Bradbury, apparso in versione più breve su «
Galaxy» nel 1951. 451 gradi Fahrenheit è la temperatura a cui la carta si accende per combustione spontanea: i pompieri, protagonisti di questo romanzo, non sono incaricati di spegnere gli incendi, bensì di dar fuoco ai libri, alle riviste, e a ogni fonte (proibita) di sapere stampato su cui arrivano a mettere le mani. Bradbury immagina un mondo anti-intellettualistico da cui è bandito lo studio personale, dove la meditazione individuale costituisce un crimine, e dove tutti passano la vita davanti a enormi schermi televisivi che funzionano in permanenza e li istupidiscono con interminabili storie sentimentali e concorsi. La città tutta è un mostro meccanico che anestetizza le coscienze piegandole al più ottuso conformismo, sradicandole dalla realtà. Montag, il protagonista, è un pompiere cui capita per caso tra le mani un libro: poco per volta comincia a leggere e a nascondere libri in casa. Denunciato dalla moglie alle autorità, sarà costretto a fuggire disperatamente per evitare la feroce caccia all'uomo scatenata dalle autorità cittadine contro di lui. Braccato, troverà salvezza in una piccola società di ribelli, paria come lui, che hanno rinunciato ai falsi valori della civiltà attuale per accudire gli autentici valori della cultura, trovando una ragione di vita nella conservazione dei pochi testi letterari rimasti. Montag, come gli altri ribelli, dovrà imparare a memoria questi testi per mantenere una cultura e una tradizione che nessun «pompiere» e nessun fuoco possano distruggere.
Altrettanto importante nello sviluppo del filone antiutopistico è
Distruggete le macchine (Player Piano, 1952) di
Kurt Vonnegut jr. È la storia di Paul Proteus, giovane dirigente d'industria di una società apparentemente utopistica, in cui tutti possono godere di un notevole benessere. A nessuno mancano i moderni lussi e comfort, e le macchine svolgono quasi tutti i lavori un tempo compiuti dagli esseri umani. In realtà, dietro questa facciata paradisiaca, si nasconde la profonda ingiustizia di un mondo automatizzato che è proprietà esclusiva dei tecnocrati, dei grandi impresari industriali, degli ingegneri che si tramandano il potere come nelle antiche caste medioevali. Soltanto i pochi eletti, i pochi appartenenti alla nuova aristocrazia possono accedere al potere, e i giovani «cadetti», i futuri successori degli odierni dirigenti, devono dimostrare non le loro qualità e capacità effettive (ormai il passaggio dinastico e clientelare è diventato automatico) bensì di possedere lo «spirito aziendale» una cieca fiducia nel sistema: nessun dubbio, sia pur minimo, viene accettato. Nessun mezzo viene trascurato per inculcare nei futuri padroni del paese lo spirito aziendale: ritiri annuali per accendere lo spirito di corpo, gare ginniche dal vago sapore nazifascista, «sacre rappresentazioni», opere teatrali in cui le forze del bene (i Giovani Ingegneri) sono contrapposte a quelle del male (i demoniaci Radicali). In contrasto con questa casta di aristocratici chiusi nelle loro cittadelle corazzate, i cittadini comuni, quelli non qualificati per svolgere le mansioni direttive, vivono in autentici ghetti e, pur di sottrarsi al grigiore di un 'esistenza vuota e inutile, si irreggimentano nell'esercito o nel corpo di bonifica stradale, attività più simboliche che reali, mentre le macchine vanno sostituendo sempre più l'uomo anche nei lavori di tipo intellettuale.
Comunque le macchine sono solo il bersaglio apparente di Vonnegut; in realtà egli le considera strumenti di indubbio valore e utilità. La violenta protesta dell'autore e del giovane protagonista è diretta contro la burocrazia tecnocratica, una vera e propria dittatura di classe che detiene il potere manovrandolo in nome di un'etica ipocrita e utilitaristica, magnificando le ricchezze materiali prodotte dalle macchine senza minimamente preoccuparsi della degradazione morale, dello svilimento intellettuale dei cittadini medi.
I limiti classisti della società capitalistica attaccata da Vonnegut sono anche il bersaglio di numerose satire di
Frederik Pohl: in
Il morbo di Mida (The Midas Plague, 1954) ad esempio, egli descrive una Terra futura in cui i robot producono in sovrappiù rispetto ai fabbisogni dei cittadini, che sono «costretti» a consumare mensilmente un certo numero di scorte.
Il tunnel sotto il mondo (The Tunnel Under the World, 1954) è un'altra violenta polemica contro il consumismo e il potere dei grandi monopoli industriali: qui l'onnipotente mr. Dorchin, rappresentante di un colossale «trust», ha innestato le menti degli abitanti di una cittadina distrutta da una casuale esplosione in corpi d'automa. L'intera cittadina ricostruita viene così ridotta alle condizioni di laboratorio: modello perfetto per le ricerche di mercato in cui sperimentare le reazioni del pubblico alla vendita di determinati prodotti. E ancora in
The Waging of the Peace, (1959), Pohl narra l'eroicomica impresa miseramente fallita di quattro volontari che tentano di fermare le terrificanti fabbriche dell'America del futuro, completamente automatizzate, le quali producono con ferrea programmazione una marea di prodotti che nessuno vuole più usare e consumare.
L'era della follia (The Syndic, 1953) di
Cyril Kornbluth contrappone invece il Sindacato, una potente organizzazione libertaria, alla Plebe, sorta di stato fascista-socialista che governa con mano ferrea.
Ancor più vicino ai canoni della tradizionale antiutopia alla Orwell o alla Zamiatin è
Doomsday Morning (1957) di
Catherine L. Moore. Qui ritroviamo infatti tutti i connotati tipici di questo genere di utopie negative: il presidente Raleigh, capo di questo mondo futuro, è vicino parente del Grande Fratello di 1984 e, come lui, anche se è salito al potere in epoca non lontana, viene ormai considerato un dio immortale, onnisciente e onnipotente. Anche qui ritroviamo un sistema che controlla costantemente ogni azione e ogni spostamento, persino ogni pensiero dei cittadini: il «Comus», un organismo che presidia tutti i mezzi di comunicazione e assicura in pratica al dittatore il suo potere assoluto.
Un altro autore degli anni cinquanta che riecheggiò, più o meno pedissequamente, i temi classici dell'antiutopia alla Orwell, è
Louis Charbonneau, che nei suoi romanzi
No Place on Earth (1958) e
The Sentinel Stars (1963) descrisse società opprimenti e dittatoriali di tipo comunista, in cui gli esseri umani venivano divisi in classi sociali invalicabili.
The Sentinel Stars narra appunto la vicenda del cittadino TRH-247, che si innamora di una ragazza appartenente a una classificazione diversa dalla sua e quindi a lui negata dalle rigide regole dello Stato.
In tempi più recenti
Alfred Elton van Vogt in
Future Glitter (1973), ha ripresentato questi concetti in termini ancora più drastici: se da una parte Lilgin, il suo dittatore, ha pacificato il mondo, eretto un sistema efficiente e ordinato, debellato il crimine, livellato le diseguaglianze, dall'altra egli pretende la sottomissione incondizionata, l'uniformità più totale alle direttive superiori anche per i più semplici e naturali atti dell'esistenza, l'ubbidienza più cieca a ogni suo capriccio. Lilgin è una figura classica di dittatore antiutopico ed esempio allarmante della massima degenerazione del potere nelle mani di un unico uomo. Il battito delle sue mani produce tuoni fragorosi, il suo volto occhieggia da ogni muro, le sue «braccia secolari» arrivano dovunque, le sue direttive sono legge assoluta. Ha anche una caratteristica originale rispetto ai suoi predecessori: il dono dell'ubiquità.
La fantascienza moderna ha in genere trascurato il filone delle antiutopie tradizionali basate sulla degenerazione del potere (sia esso politico che teocratico, tecnocratico, economico, industriale, ecc.). Le antiutopie attuali sono infatti incentrate su temi diversi ma altrettanto drammatici, come la sovrappopolazione e l'inquinamento. Autori come
John Brunner e
Harry Harrison si sono soffermati a dipingere visioni allucinate di una Terra futura depredata di tutte le sue risorse naturali, ridotta a un immenso letamaio in cui miliardi di esseri umani si combattono lo spazio vitale tra assassinii, sabotaggi, rivolte. In questo senso
Make Room, Make Room (Largo, Largo, 1966) di
Harry Harrison,
Il gregge alza la testa (The Sheep Look Up, 1972) e
Tutti a Zanzibar (The Stand on Zanzibar, 1969) di
John Brunner sono modelli esemplari del più cupo e nero pessimismo antiutopistico e della più totale degenerazione della razza umana.
Un'altra possibilità futura che ha sempre molto affascinato gli scrittori di fantascienza è quella dell'olocausto atomico, della fine del mondo (o almeno del mondo civile come viene inteso oggigiorno) causata dallo scoppio di una guerra nucleare. È impossibile citare tutti i romanzi e racconti che, a partire soprattutto dagli anni quaranta (quando venne scoperta la bomba atomica), hanno trattato questo soggetto da tutte le angolazioni possibili e immaginabili: polluzione dell'aria, radioattività, mutazioni genetiche, crollo della civiltà tecnologica, ritorno alla barbarie, rinascita e ricostruzione della società. Ricordiamo, solo per fare qualche esempio dei più famosi,
Rebirth (1934) di
Thomas Calvert McClary,
The Death of Grass (1956) di
John Christopher,
Earth Abides (1949) di
George Stewart,
Level 7 (1959) di
Mordecai Roshwald,Alas Babylon (1959) di
Pat Frank,
The Long Loud Silence (1952) di
Wilson Tucker,
Lot (1953) di
Ward Moore,
Davy (1964) di
Edgar Pangborn,
A Canticle for Leibowitz (1960) di
Walter Miller jr. e in particolare anche il bellissimo e toccante
The Place of the Gods (1937, noto anche come
By the Waters of Babylon), di
Stephen Vincent Benet, un racconto che mescola paura, superstizione e pungente nostalgia nella vicenda di un ragazzo barbaro che si trova di fronte alle meraviglie tecnologiche di una città in rovina. Il suo finale, che si chiude con le parole «Dobbiamo ricostruire di nuovo», e questo tocco di sentimentalismo sono tipici di molte di queste storie, ma sono soprattutto indice di uno spicchio di speranza che c'è sempre nella migliore fantascienza.
Per concludere con le parole ancora di
James Gunn, «
qui vediamo la fantascienza che ci fa osservare l'orrore totale e definitivo dell'olocausto: un orrore che nasce non dal fatto che tanti uomini possono morire in maniera così dolorosa e orribile (tutti gli uomini sono destinati a morire, e poche morti sono piacevoli), ma che in questo modo verrà distrutto il futuro dell'umanità, verranno cancellati tutto il potenziale mai completato, tutte le possibilità mai realizzate, tutta l'arte, tutto l'amore, tutto il coraggio e la gloria che sarebbero potuti essere; non si tratta del fatto che qualche stupida guerra totale possa distruggere il presente, ma che potrebbe distruggere l'eternità. Da questo punto di vista, dal punto di vista dei nostri lontani discendenti, non importa quanto saranno diversi da noi nelle loro forme, nei loro modi di vivere e di comportarsi, il crimine più grave non è l'assassinio ma la mancanza di previsione futura, la mancanza di prospettiva che ci spinge a porre troppa enfasi su situazioni immediate con soluzioni drastiche, senza badare ai rischi per la vita e la civiltà. Una specie di idiozia romantica. In senso metaforico la fantascienza potrebbe esser considerata come un insieme di lettere dal futuro, dai nostri figli, che ci incitano a essere più riguardosi nei riguardi del loro mondo. Nel suo trattare il futuro, anche se in modo pessimistico o in una vena di «messa in guardia», la fantascienza può essere considerata una narrativa ottimistica.»